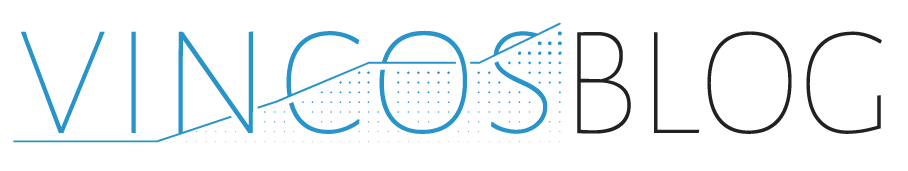Ci sono metriche che vengono utilizzate dalle aziende senza avere una chiara idea delle conseguenze, a cuor leggero. Potrebbe sembrare esagerato ma, se ci riflettete, le metriche che adottiamo oltre a permetterci di interpretare la realtà, la plasmano perché stimolano un’azione del manager che ha un impatto, positivo o negativo, sull’azienda.
Il problema è che quando non c’è modo, o non c’è un modo semplice, di misurare un fenomeno complesso, il marketer inventa i modi più fantasiosi per farlo. E tutti gli altri seguono la scorciatoia scovata da quelli che sembrano più furbi (ma spesso sono solo i più motivati, a volte sono i marketer delle aziende/agenzie/tech company che forniscono prodotti e servizi alle aziende).
Dando per scontato che i marketer si siano lasciati alle spalle i like e i follower, vediamo alcune di queste metriche pericolose o quanto meno scivolose, che andrebbero maneggiate con cura.

Advertising Value Equivalent (AVE): è la metrica su cui si regge il lavoro delle pubbliche relazioni. Il compito di quello che una volta si chiamava ufficio stampa è quello di tessere relazioni con i giornalisti e costruire notizie meritevoli di essere pubblicate. Il risultato dell’azione è dato dalla copertura stampa ossia dal numero degli articoli usciti sui vari media (giornali, web, radio e tv). Ma la semplice conta delle uscite non offre numeri di impatto tale da poter essere sfoggiati ai piani alti per giustificare la spesa per le PR.
Così qualcuno si è inventato l’AVE. Una metrica che servirebbe a calcolare il valore equivalente di un investimento pubblicitario. In pratica, per ogni articolo si calcola la superficie occupata sul giornale e si controlla quanto sarebbe costata se fosse stata acquistata per una pubblicità. Stesso ragionamento per le uscite in radio e tv, ma qui si calcola il tempo equivalente di uno spot.
La soluzione è ingegnosa ma ci sono due problemi. Il primo è che paragonare uno spazio pubblicitario ad un articolo nel quale viene citata l’azienda è una forzatura (la pubblicità ha un impatto immediato, difficile non vederla anche se di sfuggita, l’articolo va letto. Inoltre brevi citazioni del brand o articoli dedicati solo al brand cliente spesso vengono messi sullo stesso piano).
Il secondo è che il calcolo, solitamente, viene fatto prendendo come riferimento i prezzi di listino quando nella realtà il prezzo reale può arrivare ad essere anche del 50% più basso.
Media Impact Value: quando ha iniziato a diffondersi l’abitudine delle aziende di coinvolgere gli influencer per le proprie attività di comunicazione, qualche agenzia ha iniziato a proporre un KPI di sintesi basato su formule proprietarie (e quindi spesso oscure). In alcuni casi gli elementi della formula vengono esplicitati, come nel caso di una nota agenzia. Il MIV di un post o di una campagna tiene conto dei seguenti elementi:
- il numero di follower dell’autore
- le tariffe medie delle campagne di influencer marketing fatte dall’agenzia fornitrice
- un punteggio sulla qualità dell’autore (basato sulla frequenza dei post, sull’engagement medio e sull’autorevolezza dell’influencer)
- un punteggio sulla qualità del contenuto (basato su valori che includono engagement, foto, tipi di #hashtag, numero di brand citati)
Tralasciando l’inutilità di valutare i tipi di hashtag usati, è evidente che si tratta di elementi troppo eterogenei per essere mescolati in un unico risultato. Inoltre è chiaro che i punteggi di qualità essendo soggettivi si prestano ad essere attribuiti col qualche grado di soggettività.
Engagement Rate: alla nascita dei social media, la stella polare dei marketer erano i fan e i follower. Poi, quando iniziarono a capire che quelle vanity metric erano vuote, si affezionarono all’ER. Perché? Perché tolti i fan/follower, l’unica metrica visibile rimasta era quella delle interazioni. Ma le interazioni medie non rendono paragonabili due account diversi. Un rapporto che relativizza il successo acquisito nel tempo dei soggetti da paragonare, si. E così nacque l’ER che confronta interazioni e fan/follower e che permette di fare dei confronti. Così se un account Instagram ha un ER del 3% e quello di un competitor o di un account simile ce l’ha del 5%, è immediato capire chi è più forte.
In realtà questa indice è molto insidioso (ne avevo parlato approfonditamente in un post nel 2019). Il suo limite maggiore è che rappresenta il rapporto tra un valore attuale (interazioni) e un valore cumulato nel tempo (follower), tra un flusso e uno stock. Tra l’altro le interazioni possono anche essere lasciate da persone che non sono follower, ma che hanno visto il contenuto perché “spinto” dagli algoritmi di visibilità delle piattaforme.
Impression: le impression misurano le visualizzazioni di un contenuto, organico o sponsorizzato. Potrebbero essere una metrica interessante almeno per verificare il livello di circolazione di un contenuto digitale, se non fosse che il metodo di calcolo cambia da piattaforma a piattaforma.
Google Ad Manager calcola una impression non appena la creatività inizia a caricarsi sul dispositivo dell’utente (non è necessario che sia vista). Molti Ad server contano anche le pubblicità bloccate con un software di ad blocking. Facebook considera il numero di volte in cui un’istanza di un’inserzione è visibile sullo schermo per la prima volta (se un’inserzione è visibile sullo schermo e una persona scorre verso il basso, poi verso l’alto e visualizza ancora la stessa inserzione, viene calcolata una impression. Ma se una persona vede un’inserzione in due momenti diversi del giorno, le impression saranno due).
IAB e Media Rating Council hanno introdotto il concetto di viewability: affinché un annuncio possa essere considerato visibile deve avere almeno il 50%
dei suoi pixel in vista sullo schermo dell’utente per almeno un secondo (nel caso della display standard) o due secondi (nel caso del video).
Insomma il dato delle impression va quantomeno approfondito per capire come viene calcolato.
Reach Cumulata: la reach, da non confondere con le impression, è un ottimo indicatore del numero di persone effettivamente raggiunte da un contenuto (ovviamente bisogna fidarsi delle piattaforme che forniscono questo indicatore). Il problema sorge quando le aziende chiedono di sommare la reach dei singoli post pubblicati al fine di ottenere la portata mensile complessiva. L’idea è quella di “pompare” i risultati raggiunti agli occhi del top management superficiale, ma così facendo si duplicano più volte le stesse persone. Meglio sarebbe optare per una media mensile, ottenibile dividendo per il numero di post scritti.
Se conosci altre metriche scivolose, segnalamele nei commenti. Grazie!